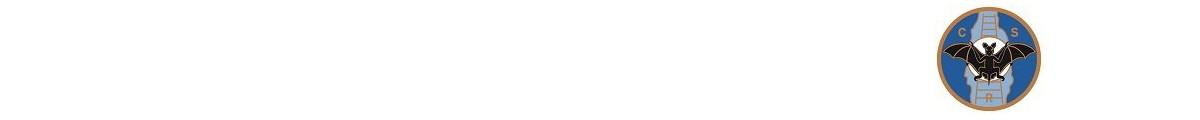di Andrea Gobetti
Una spedizione speleologica italiana nel cuore inesplorato della selva messicana, tra neri abissi e un immenso reticolo di fiumi sotterranei. “Avanzare colà è il trionfo della bestia sull’uomo. Guadiamo torrenti, ci inerpichiamo per orribili dighe di tronchi, arbusti e fango trascinati e ammucchiati dalle piene, arrampichiamo appesi alle liane per risalire brevi cascate”
Da una parte noi sei. Dall’altra, Baffo di Rame. In mezzo, la sua scrivania. Ci tira sopra un pacchetto di foto, a colori. Ci pieghiamo sul piano della scrivania, sembrano foto di buche da golf, tra l’erba verde, inquadrate dall’alto. Guardiamo meglio: un tappeto verde e un buco nero, altro non c’è. Qualcuno tra noi è arrivato da lontano per rispondere alla chiamata di Baffo di Rame. Un controllo meticoloso ci rivela che sono cinque diversi buchi neri sul medesimo tappeto verde. “E allora?” domanda Pinzimonio. “Ti sei messo a fotografare buche di biliardo?”. “Bene!”, sogghigna Baffo di Rame, “è così che vi voglio: ignoranti, tanto ignoranti da non aver mai paura”. Cùcùlo ora si insospettisce: “Mo’ ci spieghi, ci spieghi che son ’ste foto”.
Baffo di Rame non ha problemi: “Sono dove andremo tra sei mesi, banda di sbandati. Sono foto scattate da un aereo, il verde non è erbetta, sono alberi alti cinquanta metri”. Lilliput è un genio dell’equivalenza: “Ma allora… se quelli sono alberi alti cinquanta metri, quei buchi sono…”. “Sono sotani, sono pozzi nella giungla con un diametro tra i duecento e i trecento metri”, precisa Baffo di Rame. Ci pieghiamo sulle fotografie come le sbarre di un passaggio a livello all’irrompere dell’ultimo treno per Juma, ci morsichiamo l’un l’altro le dita per conquistare la lente d’ingrandimento messa in palio da Baffo di Rame. Anche con la lente il fondo di quei pozzi non si vedeva, perduto nella profonda oscurità in cinque casi su sei. Nel sesto sì. Si trattava di uno dei sotani più grandi, era largo più di trecento metri e in fondo ospitava una verde, improbabile foresta sprofondata, pure attraversata dalla traccia di un fiume. E un letto di fiume si vedeva ancora uscire dalla terra a poco più di un chilometro dalla bocca del sotano, una traccia che si poteva seguire sino alle sponde di un lago assai grande. Nell’angolo basso a destra di ogni fotografia era scritto in piccolo: «Selva del Mercadito, Oaxaca, Mexico».
La prima reazione naturalmente fu di fuggire, mescolarsi con diligenti universitari che lì vicino allignavano a frotte, nascondersi in un cesso, in un cinema. “Ohmmammamia!”, giaculò Bambàra, “non ho mai visto niente del genere…”. “La vedrai!”, tuonò Baffo di Rame. “Le porte sono barricate dall’esterno. Siete tutti volontari”.
“Viva la democrazia! Viva il Circolo romano di Speleologia!”.
Da un cassetto della scrivania di Baffo di Rame, illustre zoologo, uscirono sette bicchieri e una pinta di alcol per lupi. Brindammo.
Quando la pinta di torcibudella e un’altra sua sorella si furono asciugate, Baffo di Rame organizzò la spedizione. “Ci vediamo il trenta novembre all’hotel Bonanpak in Tuxla Gutierrez – Chiapas. Andate in grotta da abbastanza tempo per sapere quel che ci vuole per esplorare mostri del genere. Portatevelo dietro, quindi. Ora io vado a terminare il mio tredicesimo volume sulla disinvolta etologia del Neobisium Barrierii, pseudo-scorpione dalle peculiari capacità di adattamento”. Ciò detto, ci licenziò. Seguì un periodo di meticolosa preparazione. Ogni tipo di materiale: corde, canotti, amache, zanzariere, fornellini, generi di prima sopravvivenza, fu pesato, selezionato, inventato. I pacchetti di sigarette e l’alcol ridotti in vista delle feste che sempre precedono una buona partenza. Imparammo tutto quello che Tex Willer e compagni sapevano dire in spagnolo. Tutti, dal tabaccaio di fiducia alla mamma dell’esploratore, erano d’accordo su un punto: attenti ai serpenti! Il Messico appartiene a quelle regioni del mondo il cui possesso l’uomo deve spartire col signore del veleno. Studiammo a fondo le abitudini mattiniere e notturne di crotali, coralli e settepassi.
Di brutte bestie pareva fosse gremita la nostra meta, il peggiore però era un sauro, chiamato Eloderma: a differenza dei serpenti, sempre travestiti da radici e ramoscelli, l’Eloderma è grasso, corazzato come un sasso addormentato al sole. Se però gli metti una mano sopra ti morde, se ti morde non ti molla più, ti pompa dentro tanto veleno, e tu urli finché non viene la morte a toglierti di lì. Finalmente venne l’autunno, gran stagione per partire. Coperti d’attrezzatura personale e collettiva quanta non se l’è mai caricata in schiena neppure il dottore Livingstone, suppongo, sbarchiamo a Città del Messico, facili prede d’ogni locale taxista abusivo, e seguitiamo la nostra disavventurosa strada nella civiltà sempre gridando che non siamo gringos, ma italiani, che non parliamo inglese, che non sfruttiamo il Centro America, che abbiamo battuto i tedeschi 4 a 3 allo stadio Azteca.
Solo Pinzimonio, vecchio residuato d’india, se la godette fino alle lacrime un’altra prima notte ancora su una sferragliante corriera dei tropici, rivedendo oltre i vetri Canopo, la Croce, le stelle del Sud abbandonate tanti anni prima sopra la torrida pianura del Punjab. Si addormentò visitato dai ricordi, mentre la strada dall’altipiano sprofondava nelle gole del Guerrero e l’afa notturna lo cullava: «Sei scappato all’inverno, sei scappato all’inferno». …Alla fine Baffo di Rame, blue-jeans, baffi non da rivoluzionario, bensì da esploratore inglese «fin de siècle», giacca di lino e retino da farfalle apparve nella hall dell’hotel Bonanpak a Tuxla Gutierrez – Chiapas. Aveva affittato un pullmino Volkswagen e placato i camerieri che desideravano cacciar fuori il branco dei suoi menestrelli. “Bene, stasera ci ubriachiamo e domani si va!”.
Lo applaudimmo fino alle lacrime.
Cercando ora, per un attimo, di essere serio nella narrazione delle vicende che ci portarono ad essere la Banda di Pesce Cieco, vi rivelerò che, giunti nelle selve che furono il cuore della civiltà maya, ci addentrammo in esse sino al lago di Malpaso, bacino a artificiale che abbevera d’energia l’estremo Sud messicano. Una sensazione subito morde l’anima di chi gioca all’esploratore in queste regioni, chiamate remote quando il romanticismo era giovane, e si moriva quindi di malaria e di tisi ma non di crepamondo galoppante. Ora qui si brucia la foresta e si pompa il petrolio, si brucia la foresta e si estrae l’uranio, si brucia la foresta e si piantano le banane, si brucia guardando foto aeree come le nostre in stanze piene di fumo dove grasse dita, visi pallidi e bocche insaziabili dicono “qui, quo e, qua porteremo il progresso da lì a là”. E tu, l’esploratore, ti senti utile come una crocerossina in ispezione a Mauthausen, mentre percorri i miti condannati, luoghi chiamati Lacandona, Marquès de Comillaz, Laguna de Miramar, ormai catturati nella ragnatela topografica di strade che vanno componendosi tra nomi di più moderno sognare, o rimpiangere. Libertàd, Carranza, Soledàd, Pancho Villa, Obregón, Revolución; tutti insieme ad assediare il corpo verdeggiante della selva, penultima tappa di un viaggio al suo cuore inesplorato; i neri abissi, i fiumi sotterranei, dove vive Pesce Cieco.
In due giorni di viaggio arriviamo ai contorni della foresta, alla colonia Aguablanca, sulla riva del lago più lontana dalla diga di Malpaso, nell’ansa dove si immette il selvaggio rio Engagonado. Abbiamo affittato una barca e «guida» e il suo fucile. Da veri trogloditi ci accampiamo all’asciutto, in una grotta che penetra nella sponda rocciosa del lago per un centinaio di metri, si dice che la stagione delle grandi piogge sia finita da un pezzo, comunque pare piova lo stesso un giorno sì e l’altro pure. La caverna ci protegge anche dalle grida diurne e notturne, volanti, striscianti e rampicanti della selva. Grida che spaventano, che si infilano sino al mondo dei sogni. Eppure siamo gli eroi della Pattuglia dei Paguri, il braccio-e-machete dell’evoluzionismo, quelli che sul casco portano scritto: «Evolversi o perire», il servizio d’ordine del darwinismo quando si manifesta contro la creazione invocando un’implacabile e casuale selezione naturale. Siamo in nove: Baffo di Rame, dottor Oz, Hugo Manzanilla, sommi naturalisti, loro già conoscono Malpaso e il Mercadito per averne esplorato anni fa alcune grotte, raccogliendo esemplari di specie animali sconosciute, e noi sei invece ignoranti: Lilliput, la Bestia, Bambàra, Cùcùlo, Pinzimonio e Ghiribizzo. Noi siamo speleologi che discendono dall’alpinismo, non dalla scimmia arborea, come gli illuminati pensatori che ci guidano. A noi spaventano (da matti) le migali, grandi e piccine, gli inoffensivi granchiacci Amblipigius bruttissimus e i simpatici vampiri, gli scorpioni, i serpentelli, i ragni di plastica che Baffo di Rame ci mette nel sacco a pelo, quando dormiamo, l’archibugio di José, legato col fil di ferro. La malaria, il giaguaro, l’oncocercosi, i crotali che cadono nei pozzi e non sanno più come venirne fuori, l’ospedale più vicino che è sempre troppo lontano, ma mai lontano quanto la casa di mia mamma, conclude il nostro proclama, letto ad alta voce, quel mattino del 10 dicembre, partiti a risalire la traccia del misterioso fiume; unica via, stretta tra le verdi muraglie della selva, tra il lago e la speranza di grotte lontane. Avanzare colà è il trionfo della bestia sull’uomo: guadiamo correnti, attraversiamo a nuoto pozze profonde, ci inerpichiamo per orribili dighe di tronchi, arbusti e fango trascinati e ammucchiati dalle piene, arrampichiamo appesi alle liane per risalire brevi cascate. L’ultimo brandello d’umanità, la paura del serpente travestito d’appiglio, svanisce in un gorgo di scivolare, inciampare, cadere; oltre c’è solo più Yanez de Gomera che cerca, di fronte ad ogni nuovo ostacolo, l’ennesima sigaretta massacrata nel taschino della camicia.
Dopo otto ore di combattimento, intossicati dal tabacco (si fuma troppo nella giungla, ricorda troppi film), vediamo squarciarsi il vicino orizzonte di piante ed apparire una radura, una casa, sei mucche, tre tacchini, dieci bimbi la cui sorella maggiore ci mostra orgogliosa libri e quaderni e quindi la comoda mulattiera che in un’ora ci riporta, sul far della sera, al nostro campo di Aguablanca. “Credevo fosse la guida…”, dice Cùcùlo al dottor Oz, indicando José, sempre luminoso di sorrisi dai denti alle pupille. “Sst… siamo pensatori sperimentalisti noi, mica credenti”. Cielo di piombo e pioggia, all’indomani; partiamo lo stesso. “Tra un po’ smette”, profetizza guru Ghiribizzo, e José naturalmente ride, felice. Quando sfiliamo davanti alla casa della bimba studiosa, ufficialmente chiamata colonia «La Lucha», José raccatta finalmente un po’ di informazioni, e, dopo qualche centinaio di metri, lasciamo la mulattiera che prosegue sino alla sperduta colonia «La Esperancia». Riconosciamo in un affluente di destra del rio principale il torrente tanto desiderato sulle foto aeree e dopo avere costeggiato un ultimo campo di banane lasciamo ogni traccia della civiltà. Piove, le pietre sulle sponde del rio sono viscide come serpenti, scivoliamo fuori e dentro l’acqua. Siamo già tutti bagnati fradici quando vediamo il torrente scaturire dalla terra alla base d’una scalinata di enormi macigni muschiosi. In quel caos di pietre non ci sono né porte, né orifizi per il mondo sotterraneo, bisognerà risalire la «scalinata» fra le due pareti della selva. Questa rappresenta evidentemente la traccia disseccata del fiume che ora scorre invisibile sottoterra, la nostra speranza è che il suo vecchio letto nasca da una grotta.
“Lo sapremo tra circa quattro ore”, rincuora Ghiribizzo dopo aver consultato la preziosa fotografia aerea sotto la pioggia battente.
Ci guardiamo oltre le tese dei cappellacci grondanti pioggia, non si parla più, si sputa e si scivola, ci si appende a tutto, si calpestano le mani dell’amico contratte sull’appiglio pur di guadagnare un altro metro di più; Hugo Manzanilla osserva, deliziato dai nostri costumi etologici. Ringraziamo José quando al ventesimo ruzzolone decide finalmente di togliere le cartucce a pallettoni dal fucile. Si bagnano le ultime sigarette, ridono le scimmie e i tamarindi, le foglie e i più disparati ricordi della vecchia Europa. Poi, ad un tratto, chi quel giorno prese il volo “AZ Unduetrè” tra Oaxaca e Tuxtla Gutierrez ci passò sopra la testa, sopra la foresta inesplorata, sopra la pioggia che si mescolava al sudore scendendoci giù per il collo.
Allora scoppiamo a ridere, tutti come imbecilli, noi, la specie dominante del pianeta. Finisce la salita, il letto secco del rio scorre ora sul fondo di un canyon ampio le cui pareti ci sovrastano di circa duecento metri, la valle è piena di scimmie e di pavoni neri, la pioggia rallenta e si estingue mentre nel cielo l’azzurro riesce a sforacchiare la tovaglia di piombo. Davanti a noi appare la parete che chiude la gola, ci sarà ai suoi piedi la grotta oppure il posto dove erigere una lapide a Baffo di Rame divorato dalla sua corte dei miracoli? C’è la grotta.
Un immenso portale da inferno divora il pavimento in forte discesa, le rocce sono coperte di fango secco e così anche i rami più bassi degli alberi, segno che durante le grandi piene il fiume sotterraneo balza ancora fuori da questa porta. Ci buttiamo dentro alla Mucchio Selvaggio, tutti insieme, ululando, rubandoci l’un l’altro pile, candele, carburo e cerini. Dalla bocca di pietra esce un gran vento e nel vento c’è un ruggito che non puoi confondere, è la voce del fiume sotterraneo. Attorno a noi si è fatto buio, armeggiamo coi nostri marchingegni da speleo, José stringe sempre fucile e machete, esplora la sabbia in cerca di orme, sorride al buio e ai mostri venuti dall’Europa. Non ci sono bivi e labirinti quaggiù. Ad affondare nella terra è una galleria enorme, le pareti intarsiate di vasche pietrificate; il pavimento è una spiaggia che va coprendosi d’impronte dirette verso il rombo delle rapide sotterranee.
Ci fermiamo appollaiati sopra una ripida discesa di rocce e fango. Scopriamo di aver pensato bene di dimenticare il pesante sacco delle corde ad Aguablanca, ci malediciamo mentre fasci di fredda luce elettrica scoprono la bianca schiuma della corrente vorticare cinque o sei metri a picco sotto di noi. Il fiume della notte giunge dall’ignoto di fronte e ci sparisce sotto tra le fessure degli enormi blocchi franati, sopra cui stiamo discutendo.
Fiumi sotterranei così grandi nessuno fra noi e pochissimi fra gli speleo d’Europa ne hanno mai esplorati, ma la domanda è classica: “Si tocca?”. “Ma! Prova tu”. Ghiribizzo trova una via per scendere tra i blocchi fangosi sino al pelo dell’acqua. “Ci saran mica… dei serpenti?”. “Sarà pieno, tra un gorgo e l’altro”, sibila Manzanilla, senza pietà.
Bambàra e Pinzimonio si staccano dal gruppo, salendo e scendendo tra i macigni sotto cui sparisce il fiume, cercano di raggiungere la sponda opposta.
Un urlo umano copre i ruggiti dell’acqua.
“Lààààà! Lààààààààà !!!!!”. “Che c’è?”.
Ma i due altro suono non sanno più articolare se non l’inquietante “Làlààààà”. Là è un foro di luce sospeso nel buio. Là è dove la galleria e il fiume provengono ma come fanno a venire dal mondo esterno?
“Va a finire sotto il sotano”, grida la Bestia, “sotto il gigantesco pozzo delle fotografie!”.
“Elementare Watson, elementare”, sorride Baffo di Rame.
Allora scopriamo immediatamente che si tocca, che la corrente non trascina via gli sventurati e l’acqua, né calda, né gelida, non arriva mai sopra la pancia.
Cùcùlo grida, ha visto un serpente nero e rosso che lo guarda male dalla riva, questo si lascia classificare come «inoffensivo» dai sommi zoologi e quindi fugge nel buio prima che José lo affetti a machetate.
Una spiaggia di pietre, un guado, un’altra spiaggia, il buco di luce si fa più grande, un altro guado ancora. “Aaarggh!”, urla Lilliput, “qualcosa mi ha toccato le cosce”. Qualcosa dal tocco vellutato e sinistro, come le ali dei serpenti. “Fatti furbo, bipede sedicente superiore”, sta rassicurandolo Baffo di Rame, quando la voce gli muore, gli cascano la mandibola e gli occhi in acqua e ci finirebbe dentro tutto se non apparisse dal cielo nero il fantasma di Linneo a sorreggerlo con le spesse pergamene del «Primo catalogo degli animali del mondo». Linneo, come il settimo cavalleggeri, compare soltanto nei momenti estremi della zoologia; la scoperta di nuove specie animali: Baffo di Rame ha visto Pesce Cieco.
Noi scopriamo che si può pescare anche con un retino da farfalle. Pesce Cieco è bianco, lungo una spanna, sembra un pesce gatto cui i baffoni siano cresciuti a dismisura, tra le branchie, la fronte è liscia, gli occhi sono sprofondati sotto strati di pelle e si sono trasformati in organi sensori di cui noi ancora ignoriamo la natura. I pesci nelle grotte dispongono di molto meno cibo di un ranchero texano e son sopravvissuti quelli che hanno buttato via lo spreco di vedere un mondo d’acqua buia. Chissà, quando un giorno aumenterà ancora il prezzo del carburo, se seguiremo la via di Pesce Cieco per continuare ad esplorare gli abissi? Ora, seduti sui sassi in riva al fiume, vediamo per la prima volta, con gli occhi della mente, la grandiosità del reticolo sotterraneo sepolto sotto la foresta del Mercadito: dev’essere immenso per avere permesso l’evoluzione di Pesce Cieco. La sua antichità ci sfugge, essendo il tempo ancora meno familiare dello spazio all’immaginazione di quelle scimmie che un paio d’anni fa si sono alzate in piedi, hanno acceso il fuoco e si sono fatte la barba sul petto le braccia e le gambe, per non bruciare del tutto. Riprendiamo a risalire verso il portale illuminato, appaiono Granchio Cieco e Gambero Cieco, e molti altri Pesce Cieco; non sono tutti uguali, alcuni hanno baffi più corti, pelle più scura, tracce di occhi atrofizzati, occhietti piccoli piccoli secondo una scala perfetta di adattamento successivo alla vita nell’ambiente sotterraneo, dove, come in tutto il resto del mondo, più uno ci sa fare e più trova di che mangiare e con chi fare all’amore.
Tanta visione biologica rallegrava anche noi, l’umana raschiatura di un barile di santi e navigatori, mentre camminavamo piano, tra le correnti del fiume e le isolette di ciottoli, guardando la porta luminosa disegnarsi sempre più grande di fronte a noi. Oltre, la luce stava mutando, dal verde all’argento. Qualche centinaio di passi e una luna piena, immensa, si sporse oltre l’orlo del sotano bordato di giungla, bagnò di luce bianca le sue pareti strapiombanti, sino al fondo, sino ai nostri minuscoli, occhi scintillanti.
Spedizioni Malpaso
Nell’autunno 1981 il Circolo romano di speleologia e l’Istituto di zoologia dell’Università di Roma, sotto l’alto patronato dell’Accademia dei Lincei, effettuarono una spedizione speleologica nelle grotte della foresta del Mercadito al confine degli stati messicani del Chiapas e dell’Oaxaca. La spedizione aveva compiti biologici ed esplorativi ed era la quarta d’una serie, giunta oggi al numero cinque, che sta trasformando l’inesplorato sottosuolo della giungla in uno dei più vasti complessi di grotte e fiumi sotterranei del mondo. Ispiratore e capospedizione di queste esplorazioni era ed è il professor Valerio Sbordoni. Come già nel 1971, nel ’75 e nel ’77, erano con lui il professor Roberto Argano e il dottor Vincenzo Vome- ro. Alla prima esperienza speleologica tropicale scopriamo invece i professionisti degli abissi appenninici: Stefano Gambari, Claudio Norza, Maurizio Monteleone, Tullio Bernabei, nonché il sempre vostro speleo a narratore.